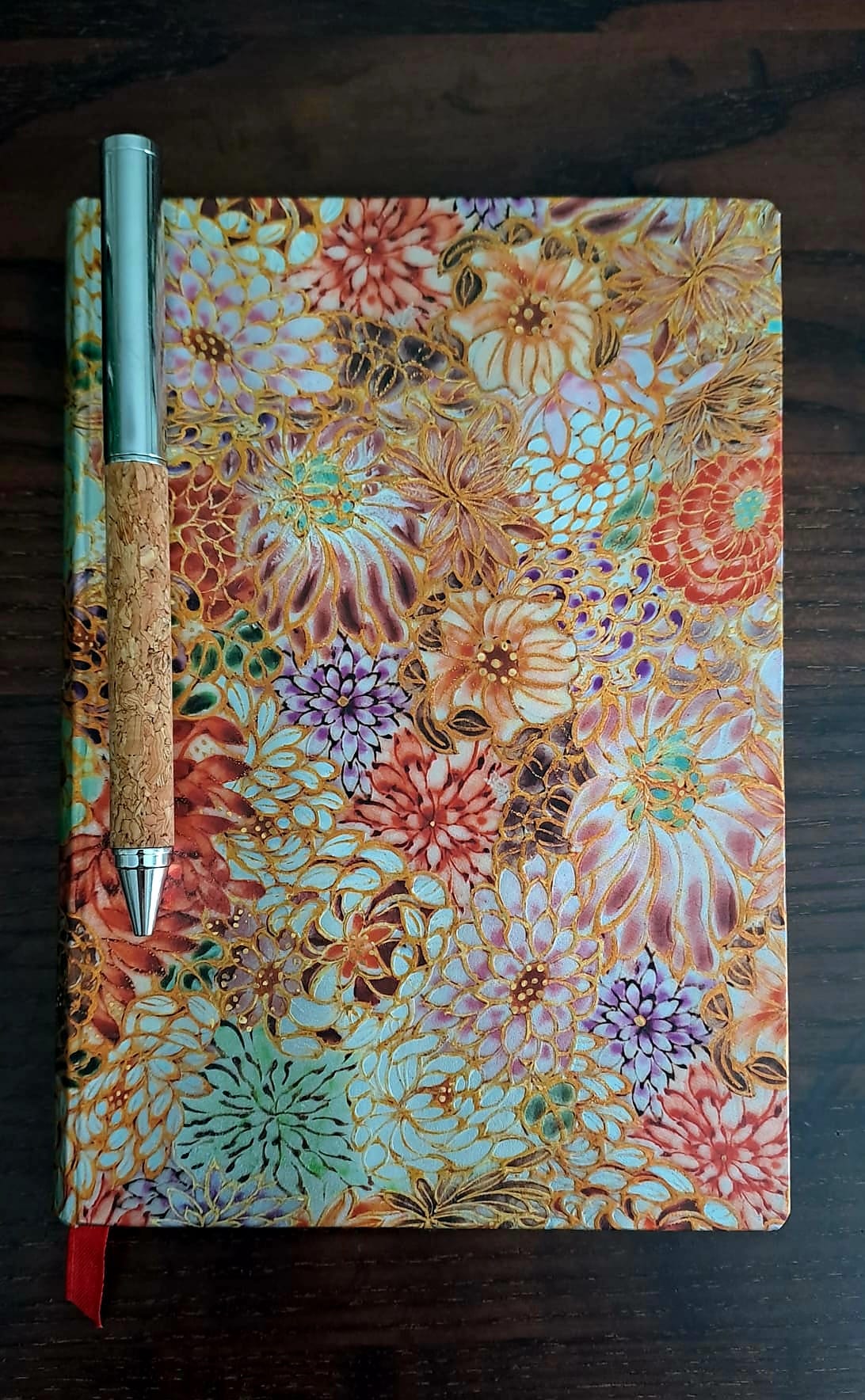Nel raccontare la propria storia, si cerca di dare un senso alla propria vita. La narrazione diventa di per sé un processo terapeutico che aiuta ad accettare ed articolare i sentimenti e a focalizzarsi sugli stati interiori vissuti durante l’esperienza narrata.
Solitamente, l’inizio del racconto è caratterizzato da forti emozioni, mentre il loro vero significato emerge man mano che la storia va avanti.
Molteplici ricerche hanno confermato, ormai da anni, che l’approccio narrativo abbia un'influenza positiva sulla salute fisica e psicologica (Pennebaker et al. 2003), soprattutto quando si espone, in forma scritta, un argomento emotivamente significativo.
Il potere terapeutico della scrittura è dimostrato dai suoi effetti curativi e salvifici, infatti, la persona che scrive dei propri traumi, arriva più facilmente ad una comprensione coerente dell’evento che li ha generati, ad una più rapida ristrutturazione del proprio sistema di schemi mentali e credenze e ad una maggiore consapevolezza circa le proprie capacità di affrontare ed accettare le situazioni complesse e dolorose.
Il Metodo narrativo, pertanto si configura come utile approccio psicologico, basato su diversi studi tra cui quelli di Dan P. McAdams che afferma: “Se mi vuoi conoscere devi conoscere la mia storia” ed aggiunge che: “se io mi voglio conoscere allora, anche io, dovrò arrivare a conoscere la mia storia”. Secondo questo autore, è importante pensare la propria vita in termini di storia, così da giungere all’integrazione delle sue varie fasi e fornire ad essa un senso di unità ed un obiettivo. Infatti, avere uno scopo facilita l’ingresso nella dimensione letteraria permettendo di entrare nel ruolo di protagonista attivo della propria vita e, in tal modo, sviluppare ciò che in psicologia si chiama “senso di agentività” cioè la nitida sensazione di essere in grado di perseguire le proprie finalità pianificando e mettendo in opera un piano d’azione attraverso le proprie risorse interiori ed esterne (sociali e ambientali). Inoltre, avere un obiettivo consente di incamminarsi verso lo stesso, orientare il comportamento verso una determinata meta e comprendere, tangibilmente, a quale punto del tragitto si è giunti o di quanto ci si stia allontanando o avvicinando.
Nella narrazione della storia di vita si diventa, pertanto, il personaggio principale del racconto e questo, di per sé, rinforza l’autostima e l’autoefficacia perché permette di osservare dall’esterno il suo valore e le sue capacità a saper gestire le difficoltà e a saper trarre un dono dal danno. In chiave psicologica, i benefici della scrittura si possono ottenere, in effetti, soprattutto se si scrive in terza persona. Anche questo è stato comprovato dalla sperimentazione che ha dimostrato che: “le persone che scrivono sempre secondo la stessa coniugazione – come la prima persona singolare – non mostrano miglioramenti” (Pennebaker et al., 2003).
Ne deriva che i pazienti che fanno maggiori progressi sono proprio quelli che imparano ad usare una prospettiva personale, alternandola ad una visione esterna, più empatica. Come? Per l’appunto, semplicemente scrivendo di sé in terza persona o creando un alter ego, verso il quale di solito si è sempre più compassionevoli rispetto a quanto lo si è nei confronti di se stessi.
Scrivere, ovvero mettere nero su bianco, infatti permette di oggettivizzare le proprie emozioni, portandole fuori di sé in modo da porvisi ad una giusta distanza, o meglio ad una giusta vicinanza. Jung consigliava ai propri pazienti di mettere in forma scritta i propri pensieri per osservarli sotto una nuova luce e, inoltre, suggeriva l’uso di un bel quaderno per valorizzarli.
La scrittura di per sé è un vero e proprio processo psicologico in quanto attiva i cosiddetti processi di transfert e controtrasfert, determinando un gioco di reciproci rimandi in cui l’autore tende a proiettare sui protagonisti, frutto della propria fantasia, estensioni di sé che trasferisce al lettore o a sé stesso ogni volta che rileggerà il proprio testo. In particolare, il transfert lo si coglie mentre si scrive, quasi avendo il sentore di ciò che il proprio scritto può provocare nel lettore o su di sé a distanza di tempo e, latentemente, questo processo può condizionare il contenuto della scrittura. Invece, il controtransfert si sviluppa di rimando, come reazione a ciò che si sta leggendo e può portare a una discordanza, percepibile in termini di dissonanza emotiva, o ad una condivisione percepibile con grande sollievo e, nel migliore dei casi, accompagnata da un pensiero come: “Oh! Finalmente ho trovato scritto ciò che vado dicendo da tanto tempo anche io!”.
A sua volta, infatti, chi legge contribuisce a costruire un immaginario visivo legato al testo, ai personaggi, alle situazioni, ai luoghi che lo scrittore magari ha appena abbozzato. Perciò, si potrebbe dire che ogni individuo che legge un libro lo co-costruisce insieme all’autore.
Ricapitolando, quindi, i processi di scrittura e lettura sono necessariamente collegati e terapeutici, infatti il Link Metodo narrativo li contempla entrambi. Qualora questo metodo sia inserito in un gruppo esperienziale la tecnica della lettura, nel qui ed ora dell’incontro, consente ai partecipanti di far circolare nuove riflessioni ed emozioni attraverso la narrazione al gruppo delle proprie produzioni immaginifiche, emozioni, immagini psichiche e ricordi. Lo scopo del gruppo esperienziale diventa un’occasione di scoperta di parti di sé, attraverso la condivisione con gli altri partecipanti che consente a tutti anche nuove attribuzioni di senso.
In ogni caso, la scrittura è un atto di responsabilità perché permette di rintracciare i propri contenuti interiori per poterli rielaborare sia individualmente, sia affiancati ad un terapeuta e/o sia all’interno di un gruppo di lettura.
Inoltre, aiuta a saper dire le cose che forse non si sapeva neanche come comunicare, attraverso uno sforzo di dedizione e quindi di amore nei confronti di chi legge, per cercare le parole adatte e disegnare, così, la narrazione da donare generosamente al lettore.
Il potere terapeutico della scrittura è anche questo: accogliere e far sentire appartenenti ad una stessa comunità ai cui membri ci si senta affini, come e più che tra consanguinei!
La scrittura si rileva quindi come un luogo di sostegno e di compartecipazione, oltre che di memoria, di contenimento, di elaborazione.
“Scrivere così come dipingere, danzare, comporre: non per dimostrare il proprio talento, per descrivere il mondo o per aiutare i nostri simili a dare un senso alla loro vita, ma per cercare di avvicinarsi a se stessi e per non perdersi di vista nel corso dell’esistenza”. (Pierre Sansot, 1999, Sul buon uso della lentezza. Pratiche Editrice, Cuneo, p. 99).
In sintesi, gli effetti benefici della scrittura si possono riassumere dai risultati emersi da svariate ricerche sull’argomento, le quali hanno evidenziato che:
- scrivere su eventi di forte impatto emotivo può produrre miglioramenti a lungo termine
- la condivisione scritta dei propri racconti rafforza l’alleanza terapeutica a giovamento dell’intero percorso di aiuto psicologico proprio perché, attraverso la scrittura, si esplora uno spazio interiore in modo condiviso e ciò permette un arricchimento in chiave di lettura ed rielaborazione di sé
- adottare, nel corso della narrazione, alternativamente la prima persona e la terza persona singolare consente di cambiare la prospettiva personale integrandola con una prospettiva esterna più empatica
- mettere in forma scritta un evento traumatico facilita una comprensione più profonda e coerente dell’evento stesso, rende meno frequente la necessità di consultare un medico, favorisce il rendimento scolastico e lavorativo
Il potere terapeutico della scrittura emerge sia quando si ritaglia uno momento di riflessione per scrivere di sé in un proprio “spazio sacro” e sia quando questo corrisponda al setting della stanza dello psicologo, qualora si scelga di adottare il Link Metodo narrativo che offre il vantaggio di potersi combinare con quasi tutti gli altri approcci terapeutici. In particolare, ben si accosta all’approccio centrato sulla persona in cui è la stessa a valutare, secondo le proprie inclinazioni personali e preferenze, quale sia, tra le modalità proposte, quella giusta per sé con cui procedere nel proprio processo di cura e nel proprio percorso di crescita personale.
“The good life is justified by the good story. And the good life story is one of the most important gifts we can ever offer each other [trad. Una bella vita prende forma grazie a una bella storia. E una bella storia di vita è uno dei doni più importanti che possiamo mai offrirci l'un l'altro]”.
(Mc Adams D. P.,1993, The stories we live by “Le storie in cui viviamo”. The Guilford Press, New York, p. 7).